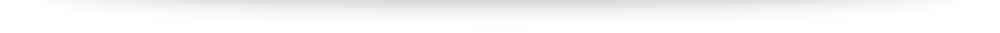Come ricordava il Papa, lunedì 4 aprile, si è celebrata la VII Giornata Mondiale contro le mine. Si tratta di una campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite per dare voce a tutte le vittime. In questi ultimi anni si parla di meno di questo argomento.
Perché? È cambiato qualcosa? 
Follie della guerra. Armi terribilmente semplici, fabbricate con pochi materiali: un involucro, una carica esplosiva e un congegno di accensione. È sufficiente una minima dimestichezza nell’uso degli esplosivi. Il web fornisce perfino manuali per realizzare ordigni antiuomo, tanto rudimentali quanto mortali. Tutti dal costo infimo.
Il prezzo è garanzia di proliferazio- ne: 3 dollari per le mine meno sofisticate e 10-15 per le più dirompenti. Molte componenti si trovano sul mercato civile. Altrimenti c’è il mercato nero delle armi, dove imperano le mine cinesi ed ex-sovietiche.
Quando esplode, una mina scatena un’onda d’urto di seimila metri al secondo. Tutto intorno la temperatura schizza fino a 4mila gradi. Il rumore è assordante, intollerabile per l’orecchio umano. Il piede investito dall’esplosione si sbriciola, insieme alle ossa della gamba. Le schegge colpiscono il resto del corpo, deturpando perfino il volto e gli occhi. Mutilano e causano emorragie. Fanno più di 10 vittime al giorno, in massima parte civili (80%) e bambini (39%).
Le avevano proibite a Ottawa, nel lontano 1999, dopo che nel 1997 il premio Nobel per la Pace era stato conferito alla Campagna Internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo. Ma le mine antiuomo continuano a mietere vittime innocenti. Perché sono l’arma più «abominevole e barbara mai concepita», come disse l’allora Segretario dell’ONU Kofi Annan. In quegli anni si era accesa una fiammella di speranza. Morti e feriti sembravano in calo. E l’obiettivo di un mondo libero dalle mine nel 2025 non pareva così irraggiungibile. Quando fu firmato il trattato in Canada, si contavano ancora 9mila vittime l’anno, ma gli sforzi degli operatori di pace stavano garantendo ottimi risultati. Così fino al 2013. Ma da allora in poi il trend si è purtroppo invertito. Le vittime hanno ripreso a crescere, con un’iperbole nel 2014. Morti e feriti sono aumentati del 12%.
L’Afghanistan ha il triste primato. Le mine colpiscono qui più che altrove. Seguono la Colombia, l’Angola, la Bosnia, l’ex-Birmania, il Pakistan tribale, la Siria, la Cambogia e il Mali del jihadismo rinascente. Di mine si muore e si soffre ancora in 63 paesi: Ucraina e Oman hanno allungato il tragico elenco, proprio quest’anno. E c’è un grido d’allarme. Guerriglieri e jihadisti stanno facendo un uso sempre più massiccio di ordigni esplosivi artigianali: i famigerati Ied, assimilabili in tutto alle mine antiuomo, come le bombe cluster.
La tecnologia delle mine si è evoluta. La bachelite ha ceduto il posto alla resina sintetica, non aggredibile dai componenti chimici del terreno e sfuggente agli occhi elettronici degli sminatori. Quando va bene, si riesce a bonificare non più di 15-20 metri quadrati al giorno. E i costi lievitano: per ogni euro speso in un campo minato ne occorrono 20 volte tanto nell’opera di sminamento. Il trattato di Ottawa è la nostra unica speranza. Oltre 160 paesi l’hanno ratificato. Ma è monco. Mancano all’appello i grandi produttori di mine: Cina, Russia, Stati Uniti, Israele e le Coree. L’India, la Birmania e il Pakistan ne fabbricano a iosa. I confini ne sono disseminati. E non ci sono dati certi sui conflitti in Libia, Mali, Yemen, Siria e Iraq.
Milleduecentoquarantatré sono i morti dell’anno scorso. Gli altri sono feriti. Di una guerra insensata. Di mine inesplose ne persistono 132 milioni, sparse qua e là, come una spada di Damocle sulle generazioni future. Individuarle è estremamente complicato, anche per il personale esperto. I più ottimisti prevedono decenni di lavoro. Forse ci vorrà anche di più. Ma non bisogna perdere la speranza. Lo insegna il Mozambico, che si è dichiarato libero dalle mine e dagli ordigni inesplosi il 17 settembre scorso. Ripartiamo da qui.